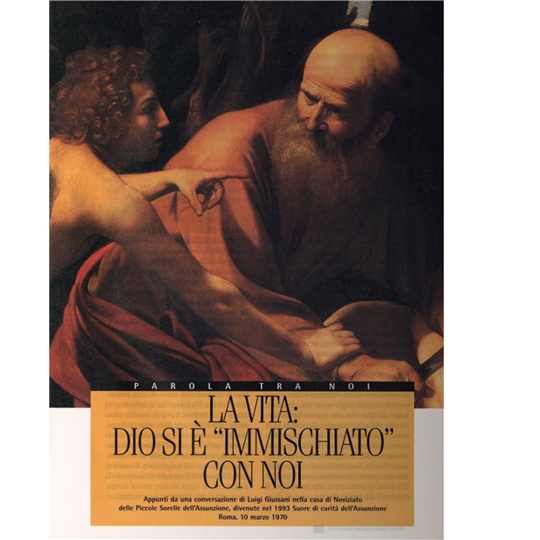
La vita: Dio si é "immischiato" con noi
Parola tra noiAppunti da una conversazione di Luigi Giussani nella casa di Noviziato delle Piccole Sorelle dell'Assunzione, divenute nel 1993 Suore di carità dell'Assunzione
Roma, 10 marzo 1970
1.«Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo". Quelli dissero: "Fa' pure come hai detto". Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce". All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella tenda". Il Signore riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: "Avvizzita come sono dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!". Ma il Signore disse ad Abramo: "Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio". Allora Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; ma quegli disse: "Sì, hai proprio riso"» (Gen 18, 1-15).
Questa prima rivelazione piena di ombre - ma già così piena di luce per noi cui la spiegazione, la parola definitiva è stata detta - del mistero della SS. Trinità è forse la pagina dell'Antico Testamento che ci commuove di più, se noi la guardiamo in faccia, se noi ci mettiamo a meditarla: è la pagina dell'Antico Testamento che ci commuove di più nel vedere quello che Dio è diventato per l'uomo.
Dio si introduce nella vita dell'uomo, e vi si inserisce con la familiarità di un dialogo, di una cena: l'essere servito dall'uomo. Guardiamo, contempliamo - queste pagine non si possono capire, se non guardandole con gli occhi, a lungo, cioè contemplandole - la figura di Abramo: «Prese del burro e del latte... e stava ritto presso di loro». Preghiamo Dio che faccia rivivere in noi tutta questa commozione ed emozione, tutta questa vigilanza piena di umiltà e di premura. Immaginiamo Abramo, lì, teso verso quei tre personaggi che erano Uno (notate questo continuo passaggio, dal singolare al plurale e viceversa, pieno di mistero); proviamo a pensare alla faccia con cui Abramo era là, teso a servirli, teso in disponibilità verso di loro, pensiamo a come l'animo, la coscienza, il cuore di Abramo doveva essere tutto come una luce; una luce non definita, perché era come un grande albore che si faceva, nella storia dell'umanità, dentro l'anima, attraverso l'anima di Abramo, giacché questo è il luogo dove il senso di tutta la storia del mondo, il senso della esistenza di ogni uomo, trova la sua comunicazione: incomincia a comunicarsi l'avvenimento con cui Dio diventa fattore dentro la nostra vita, dentro la vita dell'uomo, con cui Dio diventa come uno di noi, uno di noi, come noi.
Qui è ancora l'ombra della profezia, il primo albore, è il primo accenno; ma il valore della vita e del singolo, il valore della storia, sta in questo avvenimento. È un avvenimento ciò da cui possiamo trarre il motivo della nostra sicurezza, del nostro agire, il movente delle nostre azioni, la contentezza di noi stessi, la certezza per cui camminare: non è tanto una riflessione sul mondo, una analisi delle situazioni, ciò da cui trarre le nostre direttive, ma è lo stupore di questo avvenimento - che Dio si è "immischiato" con noi -, è lo stupore di questo avvenimento, la contemplazione di questo avvenimento. Lo stupore di questo avvenimento è l'inizio della nostra rinascita, della nostra vita. È la contemplazione di questo avvenimento il luogo dove si delineano le direttive del nostro agire.
Questo avvenimento ha dentro una definitività inesorabile, ha dentro un che di duro e inesorabile: quando Sara ha riso, Jahve l'ha osservata, l'ha rimproverata, ma non per questo ha modificato il significato della sua presenza, del suo piano. Per il fatto che Sara ha riso, egli non modifica il suo piano: «C'è forse qualcosa di troppo grande per Jahve? Al tempo fissato tornerò e Sara avrà un figlio». Tutto quanto l'Antico Testamento, la meravigliosa storia del popolo ebraico, è questo miracolo nella storia di tutta l'umanità. Tutta la storia del popolo ebraico è lo svolgersi dello stupore di questa Alleanza; di questa "Alleanza" - questo è il termine esatto - di Dio con l'uomo. Alleanza vuol dire che Dio si unisce all'uomo, che gli si unisce proprio come avvenimento della sua vita.
Tutta la storia del popolo ebraico è lo svolgersi della consapevolezza di questa Alleanza, "fila" tutta sul filo di questa Alleanza, e reca dentro di sé, continuamente, il cedimento alla tentazione dell'incertezza, alla tentazione di far scivolare la sua certezza, o meglio, i criteri dei suoi giudizi sulle sue misure. Sara che ride: «Ma devo diventare madre adesso che sono vecchia? È impossibile, è ridicolo». Di fronte a Dio, che si è introdotto attraverso l'Alleanza con esso, il popolo di Israele è come, per così dire, sempre diviso fra la figura di Abramo e di Sara, fra lo stupore attento, devoto, obbediente di Abramo e il riso di Sara, il riso incredulo di Sara. Ma Dio è fedele.
Dio rimprovera il popolo di Israele per quel suo continuo scivolare a riporre le sue speranze nelle sue misure, nei suoi idoli, nelle sue costruzioni, nelle "alture", come dice continuamente la Bibbia, «sui templi fatti per gli dei creati da lui», cioè nelle sue azioni. Dio rimprovera continuamente il popolo di Israele del suo scivolare a riporre la sua speranza, la sua stima, nelle azioni che esso compie, in quello che esso crea, nei suoi programmi, fatti sempre sulla misura della sua fantasia e della sua immaginazione, mentre Dio è incommensurabile con quelle immaginazioni, Jahve è infinitamente più grande.
«La tua speranza sono Io», Io che ti parlo; non in senso astratto - il Dio che non si è rivelato -, ma Io che mi rivelo a te. La tua speranza è poggiata sull'avvenimento in cui Io mi rivelo a te, in cui Io sto con te, la tua speranza è su questo avvenimento. Tutta la tua storia tu la devi concepire in funzione di questo avvenimento e i criteri, dunque, delle tue azioni sono da pescare in questo avvenimento, non in altro. Non devi essere adultero (come diranno sempre i profeti), introdurre i tuoi idoli, le tue misure, di qualunque natura siano.
Rimprovera Israele, Dio, ma non viene meno all'avvenimento; il suo avvenimento non viene meno: «Ripasserò da te fra un anno e Sara avrà un figlio». Bisogna leggere Deuteronomio 32, 1-52, che è una delle più belle espressioni sintetiche di tutta questa dialettica fra il popolo e Dio. Ingrassato dai favori di Dio, Israele recalcitra, cercando i propri sentieri, stimando (perché questo è il problema primo, radicale: la stima che nasce dal giudizio ultimo che si porta sulle cose) altro che non l'avvenimento di Dio; la stima di Israele si porta su altro. Dio lo rimprovera, però sempre dice: «Ma io non ritiro la mia parola». Dio è fedele, perché è giusto. La giustizia è la coerenza di Dio con il suo disegno. Così, per chi è stato chiamato da Dio, la giustizia è la coerenza al suo disegno o, meglio, è la coerenza del disegno di Dio a noi stessi, e quindi è la coerenza della nostra adesione ad esso. La giustizia è solo questo. Altrimenti il 22° capitolo del Genesi (il sacrificio di Isacco) non avrebbe nessun senso.
2. Ma dopo il capitolo 18 del Genesi dovremmo leggere gli ultimi capitoli del Vangelo di Giovanni, dal 14 al 17, specialmente il 15. Che differenza grandiosa e nello stesso tempo che continuità, che continuità profonda, fra l'Abramo e la Trinità sotto la quercia di Mamre e Gesù che non chiama più gli uomini "servi", ma "amici", perché tutto quello che egli è lo ha dato a loro, lo ha comunicato a loro! Che continuità profonda, ma nello stesso tempo che differenza abissale: come è maturata la cosa, come è compiuta! Qui è proprio compiuta, più di così si muore. Nessuno ama tanto gli amici più di chi dà la vita per i propri amici: più di così non è possibile.
Forse, il concetto che tirerà fuori san Paolo ci farà capire che più di così è impossibile: «Voi siete me e io sono voi», il corpo mistico di Cristo, carne della sua carne e ossa delle sue ossa (cfr. Ef 5, 29-32). Ma lo dice anche il Vangelo di Giovanni: «Io sono la vite e voi siete i tralci, chi rimane in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla» (Gv 15,5): senza questo avvenimento non siete più nulla. Gli altri uomini possono illudersi ancora ponendo le loro speranze nelle loro azioni, nei loro programmi. Ma voi non potete più neanche fare questo, perché chi è segnato, nel suo essere, dal coinvolgimento di Dio con lui, chi è segnato dal segno di Cristo risorto, chi è segnato dal segno definitivo, chi ha dentro di sé il seme della resurrezione finale, l'inizio della fine del mondo, come è il cristiano (che ha già dentro di sé il seme della salvezza finale, perché ha dentro di sé, nella sua carne, nelle sue ossa, Cristo risorto), non può più neanche illudersi: il dimenticare quello è un tradimento tale che subito si trova vuoto e la sua irrequietezza è molto più patologica della irrequietezza che ha dentro l'uomo del mondo. Tutta la sua azione si riduce a questa irrequietezza e a questa verità: «Senza di me non potete fare nulla». Questo è il nostro valore, questo è il valore della nostra faccia, il contenuto della nostra persona.
3. Ora, tutte le azioni esprimono quello che siamo. Perciò, questo è il motivo, il movente, il criterio, e questo è l'annuncio, il messaggio di ogni nostra azione: ciò che lui è per noi, non perché siamo capaci di fare qualche cosa da soli, come diceva san Paolo, non per le opere di giustizia che noi facciamo, ma per la misericordia con cui ci ha trattati. Per questo noi valiamo e questo è il nostro compito nel mondo: siamo stati scelti a portare questa misericordia; non innanzitutto come parola, se non come espressione della coscienza che abbiamo di noi stessi. Testimoniamo questa misericordia nella misura in cui portiamo coscienza che la nostra sostanza è lui (omnia in ipso constant, dice san Paolo). Pensiamo al primo capitolo del Vangelo di Giovanni. La sostanza di tutte le cose è Lui; ma noi siamo coloro, tra gli uomini, che sono stati scelti a capire queste cose definitive già da ora, nel tempo; siamo stati fatti parte del suo mistero, perciò questa realtà definitiva delle cose a noi è già nota. Ed è questo il compito: che portiamo questa notizia agli altri: «Andate per tutto il mondo e predicate questo evangelo, questo annuncio a tutte le creature».
Allora, tutti gli spunti attraverso cui Dio ci sollecita, tutti i rapporti in cui Dio ci impegna, altro non sono che i sentieri di Dio per questo nostro annuncio. È esattamente questo il concetto di "povertà", che costituisce il sentimento proprio e fondamentale del cristiano.
Là dove la persona è cristiana, cioè vive con la coscienza che la sua consistenza è un Altro (un Altro in essa: "Il mio vivere è Cristo"), con la coscienza che la sua consistenza, la consistenza dell'avvenimento del suo esistere, è l'esistere in essa di un altro, è l'avvenimento di Cristo che le si comunica attraverso il lungo mistero suo nel mondo, attraverso il mistero della Chiesa, corpo mistico di Cristo, il sentimento che domina la vita è la povertà. Là dove una persona vive questa coscienza, vive se stessa con questa autocoscienza - il contenuto della nostra autocoscienza è il suo mistero in noi: «Per me vivere è Cristo»; tanto è vero che il nostro nome più profondo non è il nostro nome e cognome, ma il suo: "cristiano" -, allora il sentimento della vita, il sentimento che determina l'atteggiamento della vita, la moralità (perché "moralità" vuol dire: atteggiamento da cui si genera l'azione, da cui nasce l'azione, che determina l'azione), l'atteggiamento fondamentale è la povertà.
Questa povertà è definita in un modo mirabile ed esistenziale da san Paolo, nella Seconda Lettera ai Corinti, capitoli 5 e 6. «Tutto questo viene da Dio... Vi esortiamo altresì a non ricevere invano la grazia di Dio». Cos'è questa grazia? È l'avvenimento di Cristo, «egli infatti dice: al momento favorevole ti ho esaudito, nel giorno della salvezza ti ho soccorso; ecco ora è il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza». Ma c'è un altro pezzo di san Paolo, della Prima Lettera ai Corinti, al capitolo 7, in cui questa povertà è definita in modo ancora più chiaro: «Questo vi dico, fratelli: il tempo ormai si è fatto breve; d'ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l'avessero; coloro che piangono, come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero…». Questo "come se" è veramente la formula della povertà cristiana. Il brano della Seconda Lettera ai Corinti è come il riflesso psicologico del brano della Prima, che descrive invece l'atteggiamento morale. Anzi, esso indica il livello ontologico di cui quello che abbiamo letto prima è il riverbero psicologico. Il primo brano indica la libertà, la sicurezza libera, la gioia, la pace (la vera parola è "pace", la parola che ha usato Cristo) con cui vive il cristiano. Questo secondo, invece, indica il distacco, la povertà, nella sua origine. Tendendo l'occhio al termine della nostra fede, a Cristo, a Cristo che ritorna, è come se scivolasse via tutto quello che uno fa, perché tutto quello che uno fa è un passo solo verso Cristo che ritorna. Siamo - questa è la povertà dell'uomo cristiano - come tesi fra una grazia che ci origina, nel senso letterale della parola, che ci fa nascere (vedi Nicodemo), che ci dà un essere nuovo, e la manifestazione di questo essere nuovo che già siamo. Questo è la nostra esistenza. Il nostro essere è l'alleanza di Dio con noi, non più nell'ombra che meravigliava in modo così affascinante Abramo, ma nella realtà definitiva di Cristo risorto: «Tutto quello che io sono ve l'ho dato»; nella realtà definitiva di Cristo risorto siamo già figli di Dio: anche se non appare ancora quello che siamo (Gv 1, 12).
«Fratelli, già siamo stati fatti salvi, siamo già salvi nella speranza». E la speranza è per l'emergere, il manifestarsi di quello che già abbiamo. Per san Giovanni l'attesa del cristiano non è rivolta a beni che verranno, ma al manifestarsi di un bene di cui è già possidente, perché, avendoci dato Cristo suo figlio, che cosa, con Lui, il Padre non ci ha già dato? Per questo il cristiano non è più giudicato da nessuno, non teme il giudizio: «Nessuno più ci può condannare, nessuno più può giudicarci» (Cfr. Rm 8, 31-33).
Dunque, la nostra vita è tesa fra questa grazia che ci dà di essere nuovi, che ci dà un'ontologia nuova (partecipazione a Cristo, a Cristo risorto: siamo con-risorti con lui, come dice san Paolo); fra questa alleanza definitiva, la nuova ed eterna alleanza, e la realtà di questo nuovo essere che ci viene dato dall'alleanza di Cristo, di Dio con noi, attraverso Cristo. Da questo nuovo essere che ci dà l'alleanza, si sprigiona allora un atteggiamento solo, che è quell'attesa che si manifesti quello che siamo. Tutta la nostra esistenza, come tutta la storia, è l'attesa del manifestarsi di quello che già siamo. La storia è l'attesa che si manifesti Cristo risorto, che già è; la definitività già è presente nella terra della storia, e la nostra esistenza è tutta protesa a che si manifesti quello che già siamo.
Allora, tesi fra questi due poli, la nostra vita è veramente povera, perché la sua speranza non è in nulla di quello che fa e il giudizio di valore non è poggiato su nulla di quello che fa: il nostro giudizio di valore, la nostra speranza è poggiata solo su quello che Dio ha fatto in noi, sull'alleanza che ci ha data; la speranza è sul manifestarsi di questa alleanza.
4. Ora, l'esistenza di che cosa è fatta? L'esistenza, che è la storia della persona, è fatta di azioni, che sono l'espressione, di istante in istante, della persona. Le nostre azioni debbono perciò generarsi tutte nella coscienza dell'alleanza ed essere tutte protese a manifestare questa alleanza. Nella misura in cui manifesteremo questa alleanza, in quella misura testimonieremo quello che siamo, e in quella misura anticipiamo la fine del mondo, la anticipiamo per i poveri uomini, che sono fatti per essa. Nella misura in cui le nostre azioni manifestano quello che siamo, l'alleanza di Dio in noi, portano nel mondo un anticipo della felicità finale. E questo l'uomo aspetta. Insomma, realmente l'uomo non cerca di avere due gambe o due braccia diritte, non cerca di essere guarito; l'uomo cerca la felicità, cerca il senso della perfezione della sua vita. In questo cammino l'uomo è molto più se stesso, è molto di più uomo, sente di più la vita, nella misura in cui gli è fatto scoprire il fondo della questione: e Cristo è venuto per questo, tanto è vero che non ha guarito tutti, non ha messo a posto tutti. Il compito che Cristo ci ha dato è quello di annunciarlo, non di aggiustare tutte le teste, tutte le braccia, di rendere tutti colti. Non è questo, anzi, molto realisticamente, Gesù ha detto: «I poveri li avrete sempre con voi». Nella misura di questa consapevolezza, tenuta desta dalla vigilanza (a questo punto io capisco veramente l'importanza decisiva, la grandiosità del richiamo di Cristo alla vigilanza: perché, nella misura in cui si flette la vigilanza, in quella misura torniamo ad essere mondani, perciò manchiamo a quello che siamo e facciamo come il popolo di Israele, tale e quale; e allora di fronte alla presenza di Dio, che è promessa di manifestazione, di fronte all'annuncio di ciò che è accaduto in noi, ci troviamo come Sara, ci viene da ridere, non in modo cattivo, magari; ma, dopo Cristo, è più facile il modo cattivo), nella misura in cui siamo vigilanti su quello che siamo, ci sono i due grandi corolla ri che dalla redenzione di Cristo derivano.
Da una vita diversa nasce una morale. San Paolo, quando invita i Corinti a dare del denaro per quelli di Gerusalemme in carestia, non dice: «Guardate che siete costretti a dare questo, guardate che è giustizia…», ma: «Non conoscete la liberalità di nostro Signore che essendo ricco si è fatto povero per voi onde arricchirvi nella vostra povertà...? Non è un comando che vi do, ma è un consiglio», e dopo parla dell'uguaglianza: «Quello che è necessario non è che voi vi mettiate a diventare miserabili per sollevare gli altri, quello che occorre è una certa uguaglianza» (Cfr. 2Cor 8, 8-13). Tutto, dunque, deriva dalla coscienza di quello che è Cristo. Così anche per la purità. Quando san Paolo parla della purità non dice: «È giusto che facciate questo o quello», ma: «Ricordatevi che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo».
Dalla coscienza di questa realtà nuova in noi, nella misura in cui siamo fedeli alla vigilanza, che si comunica come un albore, un crepuscolo della fine dei nostri occhi (come dice san Paolo: andiamo di chiarezza in chiarezza, rispecchiando sui nostri volti la gloria di Dio), nasce una morale nuova. Se il nostro comportamento non lo deriviamo da qui, allora la nostra situazione, il nostro modo di concepirci diventa moralistico, e il moralismo è terribile perché ci butta nella disperazione. Proprio perché Dio ci ha fatti sensibili alla vita dello Spirito, il moralismo ci butta per forza, quando ci guardiamo in faccia, nella disperazione, salvo alcuni momenti, magari i momenti di attività, in cui diventiamo, come i farisei e gli scribi, contenti di noi stessi, di quello che facciamo. Invece, derivando il nostro atteggiamento da quello che Cristo è dentro di noi, da questa ontologia nuova, da questo essere nuovo che è in noi, che il catechismo chiama "grazia santificante" (ma si tratta di capire, di vivere queste cose); se traiamo il nostro atteggiamento da quello che è Cristo, da quello che abbiamo, che siamo, dalla nascita nuova, allora siamo pieni di sicurezza, non nelle opere che facciamo noi, ma nel fatto che Dio compirà la sua storia, perché Dio è fedele. Dio è fedele, e avendo cominciato in me l'opera, la condurrà a termine.
Perciò l'unica vera preoccupazione morale in noi è quella della preghiera, cioè essere lì tesi "come occhi del servo alle mani della sua padrona", pronti ("siate pronti"). La prontezza, la vigilanza che è la preghiera, solo questa è la nostra preoccupazione: la vigilanza, che si esprime in domanda a Dio che affretti l'opera sua, che affretti la venuta del suo Cristo, dicevano gli israeliti buoni, che affretti la manifestazione di lui che è in noi.
Così, se andiamo agli altri non traendo motivo e criterio, contenuto e forma dell'azione, tutto il valore e il volto dell'azione, dalla coscienza che Cristo ci ha dato dell'alleanza di Dio, nel migliore dei casi trarremo gloria per noi stessi, e non saremo testimonianza a lui, perché ammireranno la nostra bravura e daranno gloria a noi, ma non a qualcosa d'altro da noi: non daremo gloria al mistero di Dio.
Perciò, la nostra sicurezza nella strada della vita - il Signore è venuto per renderci sicuri: tutti andavano a tastoni nel buio, cercando, finché è venuto il sole e tutto è sicuro -, la nostra sicurezza nel cammino della vita (non si può costruire se non su una sicurezza, è solo sulla sicurezza che uno edifica se stesso ed edifica il mondo), la validità, cioè la verità, la permanenza della efficacia della nostra azione per gli uomini, la verità del nostro amore agli uomini, del nostro contributo agli uomini, dipende da questa autocoscienza, che Paolo esprimeva così potentemente: "Per me vivere è Cristo". Il mio vivere sei tu, o Cristo, la mia vita sei tu, tutto quello che penso di me e tutto quello che cerco di fare viene da qui, compresa l'edificazione della Chiesa (la Chiesa è edificata da noi, dipende in proporzione matematica dalla quantità di questa nostra autocoscienza, altrimenti possiamo tutti essere cristiani e non costruire la Chiesa, nonostante tutte le buone intenzioni). La Chiesa è costruita solo dal Mistero che opera in noi, cioè da questo essere nuovo, non creato dalle nostre opere, ma da cui le nostre opere derivano, con una velocità o una lentezza secondo i tempi di Dio (in santa Teresina e santa Caterina abbastanza rapidi, in noi magari impercettibilmente lenti). Da questa realtà siamo innanzitutto cambiati noi e per questo speriamo che le nostre opere siano cambiate: non per la nostra volontà, dunque, perché se la nostra volontà facesse, potesse fare, sarebbe inutile che fosse venuto Dio. E invece tutto è grazia, cioè lo svolgersi di un avvenimento che Dio ha creato nel mondo - l'alleanza -, senza domandarci il parere prima (non ha domandato parere ad Abramo).
Il problema è che la fede non deve essere qualcosa di presupposto e lasciato lì, dato per scontato, pensando: «Adesso dobbiamo agire!». La fede deve essere l'orizzonte di tutte le azioni. Se no anche il senso della giustizia sociale è moralista, perché nasce da una posizione razionalista. Anche i pagani possono averlo e agire per esso, anzi i pagani lo fanno meglio di noi, i marxisti lo fanno meglio di noi: l'origine del loro atteggiamento è l'impeto umano di fronte al bisogno che occorre risolvere. Questo tutti gli uomini onesti lo possono fare. Allora l'impeto di fronte al bisogno idealizza il bisogno, cerca la sua teoria, cioè le sue strade, e cerca di fare il suo programma; per cui, se il bisogno è insistente, anche la violenza diventa giusta. Invece, per il cristiano non è affatto così. Il cristiano è come svegliato dal sentirsi "preso dentro" da un avvenimento che dapprima non c'entra col problema della giustizia sociale: è l'avvenimento di Cristo. La gente del Vangelo non era percossa dal problema della giustizia sociale; era lo stesso l'annuncio ai pastori e a Nicodemo («Maestro, nessuno fa quello che fai tu»), cioè ai pastori ignoranti e ai professori di università, allo stesso modo. Così, l'uomo cristiano è preso dentro da un avvenimento. L'avvenimento che Dio ha provocato nel mondo è il primum, la prima cosa nella vita: è venuto Dio, l'alleanza di Dio. Questa è la situazione nuova: è lo stupore, la meraviglia, l'ammirazione, la fedeltà a questo avvenimento. Io sono preso dentro da questo avvenimento, e questo avvenimento mi cambia e mi porta su me e sugli altri, sul mondo, con occhi carichi di un'attenzione e di una fraternità da cui deriva poi tutta l'esigenza di giustizia, di aiuto. Sembra che sia una questione magari teorica, ma ne nascono due metodi radicalmente diversi. Il secondo atteggiamento, quello che qualifica il cristiano, non lascia tregua all'inadeguatezza o all'ingiustizia che c'è, ma il suo non lasciar tregua è diverso, ha un senso più completo della questione, per cui non può portare avanti un discorso di valori schiacciando altri valori, è costretto a portare avanti tutto e perciò esige la pazienza, che è la grande parola cristiana. La pazienza è il contrario della quietitudine, dello stare passivi, è una tenacia senza fondo, che non si altera, cioè non diventa impazienza, violenza, perché è sicura, non della propria energia, ma di Cristo, di Dio che porta avanti tutto, e dei suoi tempi, soprattutto del suo disegno, della sua storia. «Colla vostra pazienza possederete l'esistenza vostra». Così non si distrugge il valore della persona per portare avanti una struttura sociale. Questa profonda differenza di metodo, che possiamo constatare in noi stessi, è forse il paragone più impressionante. Perché quando scivoliamo nel metodo moralistico, razionalistico, tutta la nostra serietà morale ci porta allo scoraggiamento, salvo i momenti in cui siamo distratti o illusi, pieni di amor proprio, di sicurezza delle nostre azioni. Ma quando ci vediamo con chiarezza, la sproporzione fra quello che siamo e quello che vorremmo essere non può non farci disperare, e così, pieni di impazienza, si fa violenza a se stessi e si dice: «Mi faccio questo proposito, in questa settimana» ed è veramente terribile. Nel secondo metodo, uno invece non cede un istante nel desiderio del bene, è tutto teso, pieno della consapevolezza del condizionamento che ha addosso e che solo il tempo di Dio purificherà e decanterà, e perciò è tutto proteso alla domanda. Tutto proteso, non al suo programma, ma alla domanda. Una domanda, infatti, non può essere sincera, se non tenendoti tutto proteso, cioè tutto pronto. Ed è questa la liberazione di cui parla san Paolo: «Liberati dalla legge». È la libertà dei figli di Dio, che non vuol dire che noi siamo perfetti: noi, peccatori, eppure così peccatori e così salvi.
È questa la contraddizione, o meglio, la tensione tra l'Alleanza, che è fondamento e origine, e la nostra storia, che rivelerà questo a suo tempo, che lo rivela secondo il tempo di Dio. È veramente quel che diceva Isaia: «A chi segue Dio spunteranno le ali come all'aquila, camminerà senza mai stancarsi» (Cfr. Is 40, 31). Mentre non c'è niente che stanchi di più dell'appoggiarci su noi stessi e sui nostri programmi. "Chi si perde si trova": la nostra vita è la vita di un Altro.
Io non riuscirei a restare cristiano, se non fossero vere queste cose; uno non potrebbe più sopportarsi né quindi sopportare gli altri, poiché non sopportiamo gli altri se non abbiamo motivo di sopportare noi stessi. Il nostro rapporto con gli altri è sempre proiezione del modo in cui percepiamo noi stessi, coscientemente o incoscientemente; in fondo, se nel subcosciente non ci accettiamo e non ci riconosciamo, non riusciamo ad accettare e riconoscere gli altri. Ma come facciamo a riconoscerci e ad accettarci con questa nullità che siamo? Ci accettiamo perché la faccia di un Altro è in noi, un'altra realtà è in noi. Non per nulla tutta la mentalità mondana accetta e tollera il cristianesimo nella misura in cui viene ricondotto a moralismo o attivismo. È la tendenza che c'è sempre stata e che la desacralizzazione o la secolarizzazione ha teorizzato fino alle sue conseguenze, per cui il cristiano è accettabile nella misura in cui identifica il suo cristianesimo con l'azione sociale e politica. Perché là dove il cristianesimo tira fuori il suo contenuto, ciò per cui è, la sua fisionomia, la sua personalità, non è più tollerabile, nel migliore dei casi è assurdo: per i "filosofi", i quali sono per la razionalità pura, per la gente colta è un assurdo (la gente colta non si sporca le mani) e lo mettono da parte; per i "farisei", vale a dire per i moralisti, per chi è impegnato con i "valori", è scandalo, non è tollerabile, deve essere strappato via. Così il liberalismo colto ha sopportato il cristianesimo, la Chiesa; il marxismo, che è molto più impegnato nella realtà, non lo tollera. Dunque, "scandalo per i giudei", cioè per i moralisti, per chi stima molto il rapporto e l'azione, e «assurdo per i gentili», cioè per la filosofia pagana.
È un altro mondo. Del resto, se Dio si rivela all'uomo, se Dio viene nella nostra storia, deve portare qualcosa che sconvolge tutte le nostre misure a priori, altrimenti non è lui. E la ricerca piena di ascolto di questo, il desiderio, la preghiera che si avveri, che la nostra realtà, la nostra carne sia modulata secondo questo avvenimento, è tutto lo sforzo cristiano, l'ascesi, si dice. Questo è il nostro compito. Io non conosco nient'altro. I giudei chiedevano i miracoli, i moralisti che si cambi il mondo, che la situazione si cambi; i greci, la sapienza, la filosofia, una concezione organica. Ma noi non conosciamo altro che Cristo e Cristo crocifisso.
Tutta la nostra preoccupazione in questi anni è che, nel mondo cristiano, si svuotino di contenuto queste frasi ultimissime, che però nessun esegeta può ridurre.





